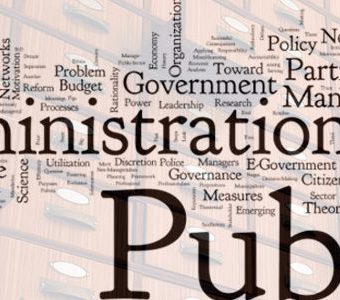Gli interessi moratori e la legge antiusura
(Relazione avv. Michele Basile all’evento organizzato da CONVENIA del 2.10.13)
La rilevanza (e in quali termini) degli interessi di mora ai fini della normativa antiusura è divenuta negli ultimi mesi una problematica che non è più solo terreno di confronto tra operatori del diritto, ma tema di stretta attualità che presagisce un incremento notevole del contenzioso, da una parte, e una opportunità di business per le associazioni di categoria, dall’altra, descrivendo uno scenario dai risvolti economici-politici inquietanti destinato ad incidere sulla situazione di crisi che stiamo vivendo, in quanto condizionante l’accesso al credito e l’intero sistema bancario.
L’allusione è in particolare ai proclami che alcune associazioni di consumatori hanno efficacemente diramato con l’utilizzo di stampa e televisione, secondo cui “il 60% dei contratti di mutuo ipotecario sarebbe nullo in quanto il tasso di interesse praticato, considerando e sommando oltre al tasso nominale annuo anche il tasso di mora, risulterebbe superiore al c.d. tasso soglia; siccome figurerebbero nei bilanci delle banche italiane mutui in essere per un totale di 800 miliardi di euro, dai quali deriverebbero interessi per 40 miliardi di euro all’anno, il 60% di questi interessi (in quanto afferenti a contratti di mutuo nulli) dovrebbe essere restituito ai mutuatari, ossia 24 miliardi di euro”.
Tralasciando la discutibile sommaria analisi di quello che, secondo tali associazioni, dovrebbe essere l’impatto economico della constatazione dell’usura bancaria e della conseguente richiesta giudiziale dei mutuatari di restituzione degli interessi percepiti dalle banche, rileva la circostanza di come, piuttosto approssimativamente, detti proclami si basino su un presupposto che è lungi dall’essere un assioma, ma che anzi è fortemente discusso: l’inclusione del tasso di mora nella base di calcolo del TEGM, prima, e del tasso soglia, poi.
L’inclusione o meno del tasso di mora nella base di calcolo del TEGM è l’oggetto dell’analisi che si intende svolgere, non senza l’avvertimento che la stessa non può essere condotta alla luce del solo dato normativo testuale.
Infatti, il rilievo che, ai fini dell’individuazione della fattispecie usuraria, svolge la complessa procedura amministrativa tesa alla determinazione del limite legale oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, impone a qualunque operatore del diritto una compiuta e prudente (ovvero disinteressata) analisi che comprenda, non solo il dato normativo testuale, ma anche e soprattutto l’intervento della normazione secondaria e i presupposti sulla quale si fonda, visto che senza la stessa la fattispecie sanzionabile (costituita sostanzialmente da una presunzione legale di usurarietà) resterebbe priva di contenuto e non potrebbe quindi essere applicata.
Non solo. Sia la normazione primaria che quella secondaria dovrebbero ricevere il vaglio di compatibilità con i principi dell’ordinamento, privilegiando la lettura più compatibile con gli istituti di diritto civile (nullità, mora, penale, etc.) e con la ratio della legge antiusura, ovvero la repressione del fenomeno usurario inteso quale limitazione del c.d. mercato illegale del credito.
L’indagine così condotta permette innanzitutto di distinguere la questione oggetto della presente trattazione, ossia la considerazione del tasso di mora come elemento di calcolo del TEGM, da altra e diversa problematica con la quale la prima viene spesso ambiguamente confusa, vale a dire l’assoggettabilità degli interessi di mora alla legge anti-usura.
In realtà, le due problematiche si pongono tra loro in rapporto di causa ad effetto, nel senso che, la soluzione positiva della seconda questione (e quindi l’assoggettamento degli interessi di mora alla legge anti-usura) genera l’altra questione, ovvero se gli interessi di mora, che il legislatore ha inteso ricomprendere nella normativa anti-usura, debbano o meno essere inclusi nelle operazioni di calcolo del TEGM ovvero soggiacere all’unico tasso soglia individuato per ciascuna operazione creditizia.
In effetti, l’esclusione degli interessi moratori dall’ambito di applicazione della legge anti- usura risolverebbe ab origine la diatriba afferente l’inclusione o meno degli stessi nel calcolo del tasso medio e sembrerebbe oltretutto maggiormente compatibile con gli altri istituti di diritto positivo ugualmente volti a presidio del debitore vessato da eccessivi interessi di mora, quali la riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c. e la nullità relativa per vessatorietà ex art. 33 II co. del Cod. Consumo (d. lgs. n. 206/2005). Del resto, a sostenere l’assimilazione della clausola penale a quella con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori, con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento di obbligazioni pecuniarie, è la stessa Suprema Corte, che ha recentemente confermato il proprio orientamento (Cass. 18 novembre 2010 n. 23273; in senso conforme, cfr. Cass. 21 giugno 2001 n. 8481).
Tuttavia, oggi non può più dubitarsi che gli interessi di mora soggiacciano al limite d’usura, ma non già perché ciò fosse nelle intenzioni del legislatore del 1996, come sostenuto dalla Suprema Corte negli anni immediatamente successivi all’emanazione della legge n. 108/96 (per tutte, Cass. 22 aprile 2000, n. 5286, che ha comunque avuto pur sempre bisogno di colmare tale labile assunto ricorrendo al principio di omogeneità di trattamento degli interessi desumibile dall’art. 1224, comma 1, c.c.).
Infatti, a dispetto di quanto andava affermando la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale invece, con ordinanza n. 236 del 22.06.2000, dichiarava inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, poiché mancanti di “qualsiasi motivazione in ordine all’iter logico in virtù del quale il remittente ritiene che la norma impugnata – dettata in tema di contratto di mutuo – sia applicabile anche alla convenzione determinativa degli interessi moratori, dovuti per il ritardo nell’adempimento di una obbligazione pecuniaria”. Evidentemente, quindi, era più che legittima la considerazione che il legislatore del 1996 avesse voluto riferirsi ai soli interessi dati o promessi “in corrispettivo” e non già a quelli con funzione sanzionatoria dell’inadempimento.
Che la legge anti-usura si applichi anche agli interessi di mora è invece una precisa scelta del legislatore del 2000, il quale con D.L. n. 394 pubblicato a fine anno e convertito in legge n. 24 del 28.02.01, nello stabilire che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti” ha inserito l’inciso “a qualunque titolo” con diretto riferimento (questa volta) agli interessi e non già alle “remunerazioni” da tener conto nella determinazione del tasso di interesse (di cui al 5° comma dell’art. 644 c.p. modificato dalla legge n. 108/96). La Relazione che ha accompagnato la legge di conversione ha puntualizzato il riferimento al tasso d’interesse, “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”.
Di fronte alla voluntas legis così chiaramente espressa, la Corte Costituzionale, ritornando sulla questione afferente l’ambito di applicazione della legge anti-usura, non più questa volta sotto il profilo della legittimità costituzionale dell’art. 1815, II comma, c.c. bensì dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 394 del 2000, ha osservato che proprio il riferimento contenuto in quest’ultima norma agli interessi “a qualunque titolo convenuti” “rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori” (Corte Cost. 25.02.2002 n. 29).
La stessa A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana), che pure opera in rappresentanza degli interessi degli enti creditizi mutuanti, intervenendo sul punto, ha chiarito nella circolare del 5.01.2001, immediatamente dopo l’emanazione del D.L. n. 394 del 2000, che gli interessi moratori assumono rilievo ai fini della disciplina sull’usura.
Se quindi solo nel 2000 il legislatore ha espressamente esteso l’ambito di applicazione della legge anti-usura, deve ritenersi legittima o almeno ampiamente giustificata l’esclusione degli interessi di mora dalle operazioni di calcolo del TEGM operata originariamente da Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano Cambi, deputati a colmare, attraverso un procedimento amministrativo culminante con la pubblicazione trimestrale dei Decreti del Ministro del Tesoro (attualmente Ministro dell’Economia e delle Finanze), il contenuto delle norme c.d. in bianco di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. (si vedano circolari 30.09.1996 e 21.08.1999).
Tuttavia, il successivo esplicito assoggettamento degli interessi moratori alla legge anti- usura avrebbe dovuto indurre un correttivo, più che nella legge, nel procedimento amministrativo teso a colmarne il contenuto, o variando gli oneri da considerare nel calcolo del TEGM, o inserendo un’ulteriore rilevazione di quello che, essendo un onere puramente eventuale (l’interesse di mora opera in caso di inadempimento), avrebbe meritato un trattamento differente.
Eppure, solo due anni più tardi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal D.M. 25 marzo 2003, provvedendo a rilevare il tasso medio ai fini della determinazione dell’usura, per la prima volta ha precisato all’art. 3, comma 4, che “i tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. Ha poi aggiunto che “l’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano Cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura hanno continuato ad escludere gli interessi di mora dagli oneri da considerare per il calcolo del TEGM e, contestualmente, i periodici decreti ministeriali hanno continuato a riportare la previsione di cui all’art. 3, comma 4.
Pur rimanendo i dubbi su quale sia la regolamentazione legislativa in materia fino all’intervento del D.M. 25 marzo 2003, la permanente esclusione degli interessi di mora dalle istruzioni per la rilevazione del tasso medio ed il recepimento da parte dei Decreti ministeriali della scelta operata dalla Banca d’Italia assumono non poca rilevanza, anche se non sopiscono le questioni connesse al trattamento degli interessi di mora ai fini dell’usura.
Ciò in quanto, se da un lato la legge ha determinato il percorso che l’autorità amministrativa deve compiere per “fotografare” l’andamento dei tassi finanziari, residuano comunque margini interpretativi rimessi alla Banca d’Italia per l’individuazione degli oneri e delle spese da includere nella rilevazione dei tassi medi di mercato, come ha ravvisato le più recente Cassazione Penale n. 12028/10.
A tale proposito fondamentale rilievo assumono le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, diramate dalla Banca d’Italia, che le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a rispettare per la rilevazione del tasso effettivo globale da essi praticato, sulle diverse operazioni, ai fini della successiva segnalazione alla stessa Banca centrale.
Tali Istruzioni sono richiamate nei preamboli dei decreti ministeriali, recepite in essi e rese vincolanti dagli stessi, i quali infatti dispongono che “le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, L. 108/1996, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia”.
Dal 1996 ad oggi si sono succedute nove versioni delle suddette “Istruzioni”, l’ultima delle quali del 12.08.2009, pubblicata sulla G.U. n. 200 del 29.08.09.
Tali istruzioni, nella versione ultima come nelle precedenti, dispongono che sono esclusi dal calcolo del TEGM «gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo» (§ C.4, pag. 14) e subito dopo precisano: «le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica».
A questo punto, risolta positivamente la querelle relativa alla soggezione degli interessi di mora al limite d’usura, ne sorge un’altra relativa al trattamento di detti interessi. Ma tale questione non può, ad avviso di chi scrive, essere liquidata esaltando il dato normativo e tacitando invece la disciplina amministrativa che riempie di contenuto la norma penale in bianco e senza la quale il reato non sarebbe punibile per mancanza di un elemento essenziale integrativo della condotta, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 644, comma 3 II parte, c.p..
Sarebbe quindi erroneo ritenere – richiamando il principio di omogeneità di cui all’art. 1224 c.c. e la pretesa assenza nella legge anti-usura di differenziazioni in base alla natura degli interessi – che, rilevato il tasso medio e determinato il tasso soglia, questo si ponga come limite sia per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori. Se non altro perché la rilevazione del tasso medio viene ad essere condotta escludendo quell’onere, onere che, pur non essendo stato considerato ai fini della determinazione del tasso medio, verrebbe poi ad essere conteggiato per confrontare il tasso d’interesse impiegato con il tasso soglia.
In realtà, la legge, demandando al Ministro del Tesoro e alla Banca d’Italia la rilevazione trimestrale del tasso medio in base al quale calcolare il tasso soglia, non sembra contenere, né limitazioni tecnico-contabili, né suggerimenti specifici alle Autorità e non pare decisiva in contrario la circostanza che si sia parlato (art. 2, comma 1, della legge n. 108/1996) di «tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese». La legge, quindi, non esclude che si possano avere altri tassi soglia oltre quello degli interessi corrispettivi, né impone l’inserimento degli interessi di mora fra le «remunerazioni a qualsiasi titolo» da conteggiare nel calcolo del TEGM degli interessi corrispettivi.
Ciò è ancor più vero se si ha riguardo alla vicenda che ha interessato le commissioni di massimo scoperto, escluse dal calcolo del TEGM fino a quando il legislatore, con la legge n. 2/2009, ha sancito l’obbligo per le Autorità amministrative, chiamate ad integrare la fattispecie di usura presunta e che si sono immediatamente uniformate (la Banca d’Italia ha modificato le proprie “Istruzioni”), di computare la C.M.S. nel tasso effettivo globale medio, prevedendo, tuttavia, che il limite oltre il quale gli interessi sono usurari resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione “fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.
Pertanto, l’analisi tesa a chiarire le modalità con le quali gli interessi di mora assumono rilevanza ai fini della legge sull’usura dovrebbe focalizzarsi sulla disciplina amministrativa che colma il contenuto delle norme anti-usura e, in particolare, sul dettato dell’art. 3, comma 4, del D.M. dell’Economia e delle Finanze del 25.03.2003, sopra enunciato, e ribadito nei successivi e periodici decreti ministeriali.
Non vale certo obiettare, come taluni hanno fatto, che la maggiorazione di 2,1 punti percentuali sia frutto di un’indagine campionaria di nessun rilievo, né che la stessa, proprio perché condotta a fini puramente conoscitivi, non sia stata più aggiornata. Tale disamina sottovaluta la circostanza che il Ministro dell’Economia ha inteso inserire la suddetta indagine e il conseguente risultato tra le principali previsioni normative dei decreti trimestrali, avvalorando la scelta compiuta dalla Banca d’Italia, ovvero quella di non “inquinare” la rilevazione del TEGM con oneri eventuali afferenti la fase patologica del rapporto di credito, ma allo stesso tempo di tenerne conto ugualmente ai fini dell’usura segnalandone l’effetto maggiorativo rispetto al tasso medio rilevato.
Il fatto poi che la detta indagine non sia stata più aggiornata è facilmente comprensibile: il tasso di mora non è un tasso “di mercato” (non c’è un mercato dei tassi di mora) e quindi non sorprende che la sua misura si mantenga costante, pur al variare del tasso convenzionale. È noto che, ove nulla sia pattuito, il tasso convenzionale si “converte” in moratorio a seguito dell’inadempimento (art, 1224, comma 1, c.c.), potendo comunque pattuirsi una misura maggiore di quest’ultimo per evitare che il creditore paghi sistematicamente in ritardo, obiettivo che non richiede un aggiornamento del tasso ai valori di mercato, che non ci sono: di qui l’aumento medio di 2,1 punti percentuali.
Leggendo ed interpretando la previsione normativa unitamente alle altre contenute nei decreti ministeriali, dovrebbe potersi agevolmente concludere che il limite della pattuizione dei tassi moratori è determinato nella percentuale pari al tasso effettivo globale medio individuato rispetto agli interessi corrispettivi, maggiorato di 2,1 punti percentuali, e successivamente aumentato di un quarto con l’aggiunta di quattro punti percentuali (tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l’art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento).
In tal senso si è espressa l’A.B.I., immediatamente dopo la pubblicazione del D.M. del marzo 2003, che, anche sulla scorta del parere reso dalla Prof.ssa Severino di Benedetto, ha inviato alle proprie associate una nota nella quale sottolineava che: “In merito a tale importante chiarimento normativo, prime autorevole interpretazioni della dottrina hanno espresso un orientamento positivo, evidenziando come il tasso soglia degli interessi moratori vada quindi oggi determinato nella percentuale prevista per gli interessi corrispettivi, maggiorata di 2,1 punti percentuali, aumentata della metà” (operazione, come detto, variata nel 2011).
La maggiorazione pari al 2,1 punti percentuali, tuttavia, potrebbe assumere valenza con una differente modalità, aggiungendosi direttamente al tasso soglia già previsto per gli interessi corrispettivi.
A conclusione dell’analisi condotta, sembrerebbero coesistere tre differenti metodologie di calcolo: la prima, basata sul principio di omogeneità, applica agli interessi di mora lo stesso tasso soglia usurario previsto per gli interessi corrispettivi; la seconda procede all’operazione di calcolo del tasso soglia moratorio dopo aver maggiorato di 2,1 punti percentuali il tasso medio; la terza aggiunge la percentuale del 2,1 direttamente al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi.
Ma, come detto, la prima impostazione non può che implicare un giudizio di illegittimità dei decreti ministeriali e delle Istruzioni di Banca d’Italia in essi incorporate, in quanto escludenti gli interessi di mora dalla rilevazione del TEGM. In quanto illegittimi, l’Autorità giudiziaria dovrebbe poterli sindacare ed eventualmente disapplicare. Tuttavia, pur ammettendo che sia possibile disapplicare i decreti ministeriali e le relative Istruzioni della Banca d’Italia, non si potrebbe prescindere dalla considerazione per cui, se si ritiene illegittima la formula di calcolo adottata dall’autorità amministrativa, tale si deve ritenere anche il risultato cui la stessa conduce. I decreti ministeriali dovrebbero, pertanto, ritenersi illegittimi anche in relazione al tasso effettivo globale medio rilevato attraverso quella metodologia di calcolo ritenuta contraria alla legge e perciò essere integralmente disapplicati. Se così non fosse, il raffronto tra un tasso d’interesse comprensivo della mora e il TEGM riportato nei decreti ministeriali si svolgerebbe tra dati non omogenei con evidente violazione dei principi di equità e ragionevolezza.
Pertanto, pretendere di confrontare il tasso effettivo applicato, comprensivo della mora, al TEGM, che non tiene conto di quell’onere, costituisce un grave errore non solo di diritto, ma anche – e soprattutto – di logica e di matematica.
Chi tale errore commette agita a scudo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 9.01.2013, ritenendo (a torto) che la stessa avvalori la tesi che anche per gli interessi di mora il raffronto vada compiuto con il tasso medio senza necessità che lo stesso venga maggiorato.
In realtà, la Suprema Corte si è limitata solo ad affermare come sia fondata la censura della ricorrente “in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., secondo comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.
Nulla di nuovo, quindi, rispetto alla coerente posizione assunta dalla Corte di Cassazione fin dall’entrata in vigore della legge anti-usura (si vedano Cass. n. 5324/2003 e Cass. n. 5286/2000): viene ribadito che il limite d’usura debba applicarsi anche agli interessi di mora, ma quale sia la corretta metodologia di calcolo non viene detto.
Sul punto, per la verità, non esistono pronunce chiarificatrici da parte della Suprema Corte, mentre si sono rinvenuti, salvo sviste, due precedenti nella giurisprudenza di merito.
Nel primo, il CTU aveva proposto al giudice due metodi di calcolo: «a) il primo (…) è stato eseguito aggiungendo la mora rilevata al tasso rilevato e poi operando la maggiorazione con il moltiplicatore 1,5 come opina la Banca d’Italia; b) il secondo (…) prevede il moltiplicatore di 1,5 applicato al solo tasso ordinario rilevato e con l’aggiunta della mora successiva, che, in questo caso, non subisce la maggiorazione del moltiplicatore». Di fronte a questa alternativa, Trib. Torino, 3 novembre 2006, (in DeJure: http://dejure.giuffre.it/psixshared/temporary/ftmp1788215771.htm) ha affermato che «tra i due metodi di calcolo alternativi l’unico corretto è il primo, per i seguenti motivi: (…) è indubbio che il divieto di usura colpisce anche gli interessi moratori e che la determinazione del pertinente tasso soglia, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari deve farsi ai sensi della legge 7.3.1996, n. 108; (…) è altresì indubbio che il D.M. 25.3.2003 e quelli successivi hanno ritenuto di non provvedere a un autonomo e distinto rilievo del tasso di interesse moratorio medio per ogni singola categoria di operazione e indicato la ‘maggiorazione media’ dell’interesse corrispettivo normalmente applicata per il caso di mora nella generalità delle operazioni. Il “tasso di interesse moratorio medio” si desume pertanto dalla sommatoria del TEGM pertinente alla singola operazione (mutuo, apertura di credito, leasing etc.) e della maggiorazione media di mora, pari al 2,1% (…). Il tasso così ottenuto, indicando valori medi di mercato in entrambe le due componenti, deve poi aumentarsi della metà al fine di ricavarne ‘il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari’ ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge n. 108».
Il secondo precedente è costituito da una sentenza del Tribunale di Nola dell’11.09.2008, nella quale gli interessi moratori, fissati nella misura di tre punti in più del tasso contrattualmente convenuto, “sembravano apparentemente usurari, siccome eccedenti il limite di legge”. Tuttavia, “ad attenta valutazione, non poteva pervenirsi ad un tale giudizio di illegittimità. Ciò in quanto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto datato 25 marzo 2003, stigmatizzava un importante principio con riferimento alla rilevazione dell’usura per gli interessi moratori, precisando espressamente che il tasso effettivo globale medio, così come rilevato per le diverse operazioni indicate, non si applica a questi ultimi – cioè a quelli dovuti in caso di ritardato pagamento – negli stessi termini in cui deve essere riferito agli interessi corrispettivi (…). Il principio sancito dall’articolo sopra riportato, pur comportando una novità rispetto ai precedenti decreti di rilevazione del tasso effettivo globale medio, si raccordava a quanto già stabilito – e sin dall’entrata in vigore della L. 108/96 – dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano Cambi, che già avevano chiarito come, difatti, dal TEGM erano esclusi gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo. Sicchè (…) al fine di determinare il tasso effettivo globale medio (e poi quello soglia) relativo agli interessi moratori, sia necessario che al TEGM stabilito per gli interessi corrispettivi nelle diverse operazioni vada applicata una maggiorazione pari al saggio mediamente applicato dalle Banche a titolo di mora per i casi di ritardato pagamento (…) individuato pari alla percentuale 2,1 per cento (…) e solo successivamente ricavare il tasso-soglia (moratorio). Laddove è incontestabile che tale differente disciplina si giustifichi per la diversa natura degli interessi considerati. Difatti, mentre gli interessi corrispettivi rappresentano il controvalore per ciò che si è ottenuto – generalmente una disponibilità di somme di denaro – gli interessi moratori mirano a penalizzare il debitore per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni e costituiscono la liquidazione operata ex lege del danno presuntivo che l’inadempimento ha prodotto al creditore. È quindi corretto che la soglia oltre la quale questi ultimi diventano usurari sia superiore – proprio per la loro natura risarcitoria – rispetto a quella individuata per gli interessi corrispettivi, tanto più che – va ribadito – nella rilevazione del TEGM non si tiene conto degli interessi di mora contrattualmente previsti”.
Oltre ai due precedenti giurisprudenziali, si segnala un interessante provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (delibera n. 161/08/CONS), reperibile sul sito dell’Autorità e avente ad oggetto “Archiviazione per insussistenza del fatto nell’ambito del procedimento sanzionatorio n. 52/07/DIT avviato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per la violazione dell’articolo 7, comma 3, dell’allegato a) alla delibera n. 179/03/CSP inrelazione all’applicazione degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento”. In questa vicenda, nell’accogliere le argomentazioni di Telecom sulla mancata applicazione di interessi usurari, l’AGCOM esclude l’usurarietà degli interessi moratori tenendo conto di quanto disposto «dall’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale, in vigore a partire dal 1 gennaio 2008, che, stabilendo che i tassi effettivi globali medi “non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento” prevede, per questi ultimi interessi, una maggiorazione rispetto ai tassi soglia, pari al 2,1%».
Nella questione, che è lontana dal dirsi definita, anche in considerazione dei netti proclami delle associazioni di categoria, ha ritenuto di intervenire (a propria difesa) la Banca d’Italia, pubblicando il 3.07.2013 dei “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura”.
Giustifica le proprie scelte e spiega Banca d’Italia che “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca dal mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria del credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora”.
Si legge ancora nella nota che “in ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (…), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui ‘la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali’. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”.
La nota conclude affermando che le Istruzioni, che contengono i criteri tecnici di rilevamento, “possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni”.
L’affermazione potrebbe apparire fin troppo ovvia, ma scopre il nodo dolente della questione: l’assenza di una previsione legislativa univoca che potrebbe indurre la giurisprudenza, soprattutto quella di legittimità, a disattendere la scelta compiuta dalle Autorità amministrative. Ed allora, la contesa può sopirsi solo mediante un intervento legislativo simile a quello adottato per le C.M.S..
Avv. Michele BASILE