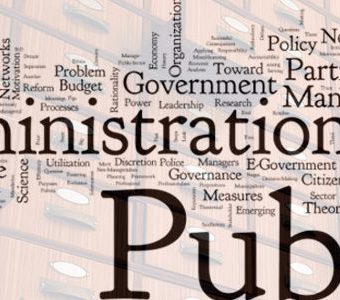Gli effetti delle misure di contenimento della pandemia sui rapporti contrattuali, con accenno alle locazioni commerciali
1. Le misure adottate per contrastare la diffusione del covid-19 hanno avuto effetto sui rapporti giuridici, provocando in particolare il mancato pagamento alle scadenze.
Imprese e privati, a causa della chiusura imposta della propria attività commerciale, della contrazione degli incassi o della perdita dei redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente, hanno ritenuto di sospendere i pagamenti di utenze, fornitori, canoni di locazione, originando in tal modo una vasta crisi di liquidità dell’intero sistema economico.
2. La principale questione, dal punto di vista prettamente giuridico, è rappresentata dalla rilevanza che l’eccezionale situazione prodotta dalla pandemia o, meglio, dai provvedimenti adottati per contrastarla, riveste nell’ambito del rapporto contrattuale, e in che termini; in sostanza, se tale situazione possa valere quale giustificazione legittima della mancata esecuzione dell’obbligazione contrattuale ovvero se possa incidere sino al punto di estinguerla.
Ebbene, ritenendo che i divieti imposti avrebbero avuto certamente impatto sui rapporti contrattuali, con il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. Decreto “Cura Italia”, convertito con modificazioni in Legge 24.04.2020 n. 27, si sono previsti alcuni rimedi per casi specifici, a titolo esemplificativo: una moratoria nel pagamento di rate di mutui e leasing, una sospensione del pagamento delle rate di mutuo riguardanti la prima casa per lavoratori autonomi e liberi professionisti, proroghe di termini e scadenze per adempimenti fiscali, sospensione dei canoni relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici, etc.
3. Con riferimento invece ai rapporti contrattuali in genere, l’art. 91 del succitato Decreto Legge, ha previsto di inserire all’art. 3 del D.L. 23.02.2020 n. 6, convertito con modificazioni in Legge 5.03.2020 n. 13, il comma 6-bis secondo cui: «Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».
Attraverso il rinvio agli artt. 1218 e 1223 c.c. la norma sostanzialmente esclude la responsabilità e il risarcimento del danno, al pari delle altre conseguenze derivanti dall’inadempimento. Tra queste, si fa espresso riferimento alle decadenze e alle eventuali penali, non alla mora né alle altre eventuali clausole (es. clausola risolutiva espressa) ovvero conseguenze connesse all’inadempimento del debitore, ma è ragionevole ritenere, alla luce della medesima ratio, che la norma possa estendersi in via interpretativa, costituendo un’ipotesi di inadempimento non imputabile o incolpevole ovverosia un esimente di responsabilità.
4. La norma tuttavia non è di automatica applicazione. Anche se può apparire sin troppo ovvio, debbono ritenersi escluse le ipotesi in cui l’inadempimento si sia già verificato ed i casi in cui la prestazione contrattuale abbia avuto scadenza prima dell’adozione dei provvedimenti restrittivi del Governo, e ciò anche se non vi sia stata la formale costituzione in mora del debitore. Parimenti debbono escludersi i rapporti contrattuali sorti nel periodo di adozione dei provvedimenti governativi di contenimento della pandemia, evidentemente conosciuti dalle parti che, ciononostante, si sono obbligate.
Nondimeno, esclusi i casi di cui sopra, non è sufficiente che l’inadempimento si sia verificato nella circostanza della pandemia per ritenere accertata l’esimente prevista dalla norma speciale.
Affinché sia integrata la causa di esclusione della responsabilità, l’inadempimento deve essere una conseguenza immediata e diretta del “rispetto delle misure di contenimento”, per cui avrebbe rilevanza la chiusura dell’attività commerciale (in quanto costituente una delle suddette misure autoritative) ma non, per esempio, qualsiasi difficoltà indotta dalla situazione di pandemia (contrazione redditi, mancati incassi, difficoltà di accesso al credito, etc.).
Oltretutto, la circostanza che la misura di contenimento che si è dovuto rispettare abbia ritardato o reso (temporaneamente) impossibile la prestazione è sempre oggetto di valutazione, come precisato dalla stessa norma speciale, per cui, in base alla regola generale in tema di inadempimento, grava sul debitore l’onere della prova di aver esaurito tutte le possibilità di adempiere adottando l’ordinaria diligenza. Ciò vuol dire che debba concretamente valutarsi, in base al caso di specie, se il rispetto delle misure di contenimento abbia costituito solo una difficoltà o invece una vera e propria impossibilità di adempiere. Ne consegue che non è esclusa la responsabilità del debitore qualora il rispetto delle misure di contenimento non sia stato tale da rendere impossibile l’esecuzione della prestazione.
5. Quanto all’impossibilità, in linea generale deve considerarsi di natura temporanea, avendo le misure restrittive carattere transitorio connesso alla permanenza del rischio epidemico.
A tale proposito, viene in rilievo l’art. 1256 c.c. che – limitandosi ad escludere la responsabilità “finché essa (l’impossibilità temporanea) perdura” – implica che la prestazione resti immutata, con conseguente obbligo in capo al debitore di eseguirla non appena l’impossibilità cessi.
Non può tuttavia escludersi l’ipotesi, ancorché residuale, che “in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto” (si pensi, per esempio, alla consegna di merce deperibile), l’obbligazione debba ritenersi estinta se, perdurando l’impossibilità, “il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”. In tale ultimo caso (e solo in questo), deriverà la risoluzione del contratto, pur se a prestazioni corrispettive, anche se l’altra prestazione è ancora possibile. Tale controprestazione, quindi, non potrà essere chiesta e, se già eseguita, dovrà essere restituita secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito, ai sensi dell’art. 1463 c.c..
6. Come visto, la norma di cui all’art. 91 del Decreto Legge “Cura Italia” – qualificando in termini di “factum principis” le misure restrittive di contenimento della pandemia e confermandone la medesima incidenza del caso fortuito e della forza maggiore sulle obbligazioni ex contractu – si limita a regolamentarne gli effetti unicamente sotto il profilo della responsabilità, escludendola; per la definizione della sorte dell’obbligazione e/o del rapporto contrattuale, invece, deve farsi riferimento alle norme codicistiche generali, in tema di obbligazioni, con riguardo alla sorte della singola prestazione, e in tema di contratti, con riferimento alla sorte dell’intero rapporto, o extracodicistiche (per es. legge 392/78 in tema di locazioni), alle quali peraltro potrà comunque farsi ricorso per quelle fattispecie non rientranti nell’ambito di stretta applicazione della norma.
7. Pertanto, qualora si valuti che le restrizioni imposte abbiano reso temporaneamente impossibile la prestazione, potrà invocarsi l’art. 1256 c.c., con la conseguenza che la prestazione dovrà comunque essere eseguita al termine del periodo di restrizione, non essendo responsabile il debitore per il ritardo nell’adempimento. L’obbligazione potrà considerarsi estinta – e risolto il contratto – solamente se “in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”. In tal caso, con riferimento agli effetti sul contratto a prestazioni corrispettive, potrà farsi applicazione dell’art. 1463 c.c..
8. Qualora invece, a causa delle misure imposte dal Governo, la prestazione risulti ancora possibile anche se divenuta eccessivamente onerosa, il debitore potrà invocare l’art. 1467 c.c., sempre che ciò corrisponda al proprio interesse, considerato che ai sensi di detta disposizione potrà domandare solo la risoluzione del contratto, essendo la possibilità di modificare le condizioni del contratto lasciata all’iniziativa della controparte.
9. Sempre con riferimento agli effetti della situazione pandemica nell’ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, qualora la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente impossibile, ai sensi dell’art. 1464 c.c. l’altra parte avrà diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e potrà recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.
10. Orbene, le succitate norme codicistiche fanno tutte riferimento al concetto di possibilità e/o impossibilità della prestazione, nonché, con riferimento a quest’ultima, al carattere temporaneo, totale o parziale della stessa, dal quale conseguono differenti conseguenze sul rapporto contrattuale.
Essenziale si presenta quindi la valutazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione che deve essere condotta con riferimento a criteri oggettivi.
A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito in quali ipotesi sia configurabile l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, sancendo che quest’ultima “si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione” (Cass. Civ. Sez. III, sent. 10.07.2018, n. 18047; conf., Cass. Civ. Sez. I, sent. 02.10.2014, n. 20811; Cass. Civ. Sez. III, sent. 20.12.2007, n. 26958). Tale orientamento giurisprudenziale appare coerente con il concetto di causa negoziale concreta elaborato dalla stessa giurisprudenza.
Non è invece possibile ravvisare l’impossibilità “nella mera impotenza economica derivante dall’inadempimento di un terzo nell’ambito di un diverso rapporto” (Cass. Civ. Sez. II, sent. 15.11.2013, n. 25777); alla luce di tale orientamento, come peraltro si è già detto, non sembra che possano rilevare difficoltà economiche originanti dalla crisi innescata dalla pandemia, dovendo l’impossibilità connettersi alla diretta incidenza del provvedimento restrittivo sulla specifica prestazione dedotta in contratto. Peraltro, tale diretta incidenza dovrà essere provata dal debitore. Sul punto, si richiama il seguente principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema d’impossibilità sopravvenuta della prestazione il debitore deve provare che l’evento non sia a lui imputabile al fine di ottenere l’esonero da responsabilità anche in ipotesi di c.d. factum principis” (Cass. Civ. Sez. II, 30.04.2012, n. 6594).
11. Alla luce di quanto detto, se appare logico escludere che i provvedimenti autoritativi possano avere effetto sul contratto di locazione ad uso abitativo, in quanto non incidenti sulla causa concreta (salva invece la possibilità che vengano a configurarsi i giusti motivi per recedere ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge 431/98), non altrettanto agevole né scontata è la valutazione da compiere rispetto al contratto di locazione commerciale.
Non si allude ovviamente alla facoltà, ove non esclusa legittimamente dal contratto, di recedere ai sensi dell’art. 27 della legge 392/1978, subordinata all’esistenza di gravi motivi che la giurisprudenza ha ritenuto configurabili anche in relazione ad uno sfavorevole ed imprevedibile andamento della congiuntura economica (Cass. 10.12.1996, n. 10980); si fa invece riferimento alla possibilità che i divieti imposti per contrastare l’epidemia si traducano nell’impossibilità della prestazione del locatore o del conduttore, presupposto delle norme codicistiche sopra richiamate e degli effetti ivi previsti.
12. Orbene, le misure di contenimento adottate nel periodo di pandemia non incidono direttamente sulla prestazione del conduttore, consistente nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie. In altre parole, il provvedimento autoritativo che abbia negato lo svolgimento dell’attività non rende impossibile la prestazione economica. Semmai quest’ultima risulterà più difficoltosa a causa della limitata redditività ovvero della mancanza di incassi, per cui, per esempio, sarà sempre possibile adempiere una volta terminato il periodo di chiusura.
Qualora, in via analogica, si configuri tale difficoltà di adempiere in termini di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, con relativo onere a carico del debitore, sarà possibile ai sensi dell’art. 1467 c.c. risolvere il contratto, ma si dubita che ciò sia nell’interesse effettivo del conduttore di un locale commerciale che intenda proseguire la propria attività una volta superato il particolare periodo caratterizzato dal rischio pandemico. Più probabile è che il conduttore miri ad una equa riduzione del canone, interesse che potrebbe coincidere con quello del locatore, laddove quest’ultimo intenda conservare il rapporto contrattuale.
13. Le misure restrittive non sembrano incidere neanche sulla prestazione principale del locatore che è quella, prevista dall’art. 1575 c.c., di mettere a disposizione del conduttore un immobile e di mantenerlo in stato tale da servire all’uso convenuto. Le misure imposte non privano l’immobile locato della sua idoneità all’uso pattuito, né lo sottraggono alla disponibilità del conduttore.
A ben vedere, tuttavia, ad essere inciso dal “factum principis” sembrerebbe invece il “pacifico godimento” che il proprietario dell’immobile non può garantire, non già per sua colpa, bensì a causa del provvedimento dell’autorità. Più esattamente non può essere garantita l’utilizzazione economica e, conseguentemente, la redditività connessa a quest’ultima.
Qualora detta utilizzazione economica costituisca la causa in concreto ovvero lo scopo pratico del contratto, conosciuto e condiviso dalle parti, potrebbe configurarsi una impossibilità della prestazione (o, meglio, impossibilità per il conduttore di fruire della prestazione del locatore).
14. È arduo tuttavia sostenere – per la natura del contratto di locazione – che tale impossibilità sia totale, con conseguente estinzione dell’obbligazione di pagamento del canone.
La locazione è infatti un contratto ad esecuzione continuata. Peraltro, secondo i principi che possono desumersi dalla giurisprudenza in tema di rapporto di locazione, l’impossibilità totale può farsi derivare solo dall’integrale indisponibilità dell’immobile, per esempio a causa di distruzione o perdita definitiva delle caratteristiche essenziali all’uso cui lo stesso era destinato.
15. Più fondatamente, può sostenersi l’impossibilità di carattere temporaneo, assimilabile seppur in via analogica ad una impossibilità parziale, che potrebbe dar luogo all’applicazione dell’art. 1464 c.c., con conseguente riduzione del canone limitatamente al periodo interessato dalla chiusura imposta dell’attività.
16. Va da sé che se l’attività esercitata dal conduttore non sia stata oggetto di divieto, rientrando per esempio in quelle attività esentate o escluse, sia più difficoltoso configurare una impossibilità, seppur parziale.
In particolare, per gli esercizi commerciali che siano rimasti aperti dovrebbe ragionevolmente escludersi che il conduttore possa invocare la tutela di cui all’art. 1464 c.c., avendo fruito dell’immobile ed utilizzato lo stesso per le finalità convenute sia pure in circostanze che ne possono aver penalizzato la redditività.
Quanto alle locazioni di immobili destinati ad uffici, se da un lato il necessario ricorso allo smart working, al lavoro da remoto e alle videoconferenze ne ha determinato una minore utilizzazione “materiale”, dall’altro lato l’operatività connessa al servizio prestato o alla funzione svolta è continuata regolarmente. In tal caso, la possibilità di chiedere una riduzione dei canoni è condizionata alla prova rigorosa di una ridotta operatività strettamente dipendente dalle misure di contenimento, con esclusione invece delle altre conseguenze indirettamente generate dalla pandemia sul sistema economico.
17. Influirà probabilmente sulla valutazione delle circostanze dell’inadempimento e quindi sulla possibilità per il debitore di invocare le tutele succitate la durata del periodo di restrizioni e, più in generale, della crisi economica indotta dalla pandemia. Tuttavia, alla luce di quanto sopra detto, potrebbe nella maggior parte dei casi risultare non giustificata la sospensione tout court del pagamento dei canoni di locazione commerciale ed esporre il conduttore al rischio di essere considerato inadempiente e di dover rilasciare l’immobile in seguito a procedimento di convalida. Appare invece certamente più percorribile ed agevole una rinegoziazione che miri a realizzare l’equo contemperamento degli interessi di entrambe le parti contrattuali, pregiudicate dall’attuale situazione. Un ruolo di rilievo, a tale proposito, potrà rivestire la mediazione ex D.lgs. 28/2010, non già in quanto obbligatoria per le cause di locazione e condizione di procedibilità delle relative domande, bensì quale strumento di opportunità ed utilità sociale che si presenta più efficace del giudizio a perseguire gli interessi concreti ed un risultato in tempi rapidi con costi contenuti.
Roma, 8 maggio 2020
Avv. Michele Basile