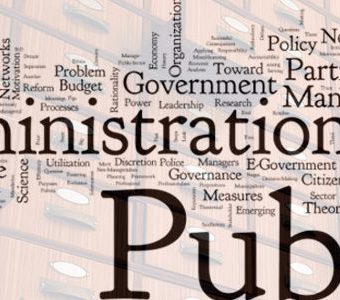La decisione delle Sezioni Unite sull’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora.
La Cassazione, con la sentenza a Sezione Unite n. 19597 del 18 settembre 2020 (scarica la sentenza a fondo pagina), pone fine alla questione che ne ha motivato la rimessione a dette Sezioni Unite e consistente nel valutare se la disciplina prevista dall’ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 c.c. e 644 c.p., nonché L. 108/1996, d.l. 394/2000, conv. L. 24/2001 e relativi decreti ministeriali) sia estensibile agli interessi moratori.
Piace constatare come lo studio MB2legal abbia già nel 2013 anticipato le conclusioni cui qualche giorno or sono è pervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite. Si rinvia alla lettura della relativa pubblicazione.
Il Collegio ha riassunto in modo sintetico ma esaustivo entrambe le tesi, restrittiva ed estensiva, riconoscendo che il dato letterale ed i diversi argomenti sovente si equivalgono tra loro, ma decisiva appare la considerazione che “il criterio-guida è costituito dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire”.
Si riportano le asserzioni più significative:
- La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.
- La mancata indicazione, nell’ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica.
- Il tasso rilevato dai d.m. a fini conoscitivi può costituire l’utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.
- Individuazione del limite per gli interessi moratori: al t.e.g.m. va aggiunta la maggiorazione per interessi moratori.
- Valido è pertanto il principio di simmetria secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente e il tasso effettivo globale della singola operazione.
- Se i decreti (quelli fino al d.m. 25 marzo 2003) non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.
- Si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro. Invero, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. La regolamentazione del mercato del credito non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all’interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l’obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all’intero ordinamento sezionale del credito, nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all’art. 1375 c.c.
- Resta quindi la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento.
- Nel caso la clausola relativa agli interessi moratori sia nulla in quanto usuraria, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull’intero nella misura dei corrispettivi pattuiti; tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito. Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l’obbligo d’immediata restituzione dell’intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all’originario piano di ammortamento non più eseguito; da tale momento e sino al pagamento, vale l’art. 1224, comma 1, c.c.
- Rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti. Ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l’illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l’effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari a tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti: effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione – presupposta dalla sentenza di accertamento pre-inadempimento – che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato.
- Nei contratti conclusi con un consumatore è dato anche il ricorso agli artt. 33, comma 2, lett. “f” e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005. Si opera quindi un cumulo di rimedi, essendo rimesso all’interessato di far valere l’uno o l’altro; ne deriva l’atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.
* * *
Sulla base delle argomentazioni, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
- <<La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso>>.
- <<La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoemo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza del predetto decreto”>>.
- <<Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.gm. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista>>.
- <<Si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti>>.
- <<Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento>>.
- <<Nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.>>.
- <<L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto>>.